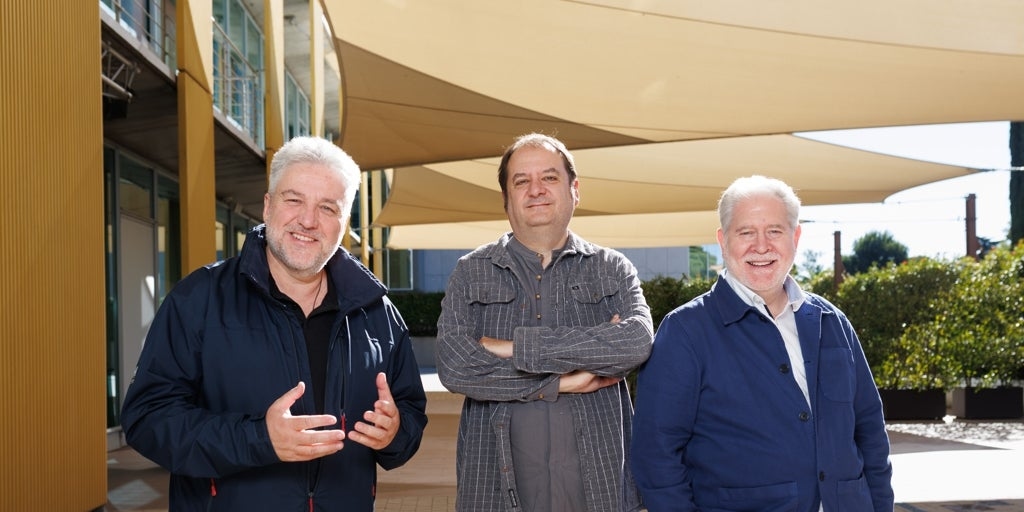Juan Sebastián Verón: il progetto dell'Estudiantes per unire calcio e istruzione

Nel suo ruolo di presidente dell'Estudiantes, promuove una nuova forma di gestione basata su trasparenza, formazione e sostenibilità economica. In "Conversations", discute del futuro del calcio argentino, della possibilità di aprire i club al capitale privato e della sfida di mantenere viva la passione mentre lo sport si modernizza.
"Gli investimenti privati non uccidono la passione. Le due cose possono coesistere", afferma Juan Sebastián Verón, che riassume così una delle idee centrali della sua visione per il futuro del calcio argentino: la necessità di innovare, professionalizzare la gestione e aprire nuove forme di finanziamento senza perdere l'essenza sociale dei club. Campione dell'Estudiantes e attuale presidente del club di La Plata, Verón si sta affermando come una delle voci più innovative quando si tratta di pensare allo sport da una prospettiva moderna, dove la passione convive con la pianificazione e la sostenibilità.
A questo proposito, in Conversations ha parlato di formazione, leadership e management, ma anche della possibilità di quotazione in borsa dei club, dell'apertura al capitale privato come motore di sviluppo e dell'equilibrio tra identità ed evoluzione. Con una visione che coniuga esperienza, sensibilità e management, l'ex allenatore della nazionale argentina propone un modello di club con solide radici e una visione proiettata al futuro.
-Bruja, è un piacere averti qui. Oggi sono alla BYMA, la Borsa argentina. Ti darò il mio PIN e ti dirò una cosa: Estudiantes si quota in borsa. Lo ha già fatto con gli assegni di pagamento differito; è stata pioniera nella trasparenza delle offerte pubbliche. E lo faremo.
Per prima cosa devi lavorarci.
Gestire un club dev'essere più difficile che gestire un'azienda. In un'azienda si possono separare le emozioni, ma nel calcio no. Chiunque può creare qualcosa, ma trascendere richiede altri valori. Tu, il tuo cognome e l'Estudiantes avete trasceso. Quali valori ritieni siano fondamentali per questo?
Appartenenza, radicamento, disinteresse per le cose materiali, amore e passione. Sono questi gli elementi che mantengono viva l'identità.
Molti giocatori tornano all'Estudiantes, anche dopo anni di assenza. C'è qualcosa di diverso lì.
Sì. Tornare al club ha diversi significati. C'è un aspetto personale, ovviamente: il desiderio di tornare al punto di partenza. Nel mio caso, prendere l'autobus, camminare fino allo stadio, quelle piccole cose che ti formano. Nel tempo, il club è cambiato, come tutto, ma ha ancora quel filo conduttore: è un club che ti accoglie. Dal momento in cui arrivi, tutti sono lì per te; fanno di tutto per farti sentire bene. Si vede. I tifosi dell'Estudiantes hanno un legame diverso con i loro giocatori. C'è un livello di pretesa, sì, ma anche di affetto.
Quando ho iniziato, il club era difficile. Non direi abbandonato, ma sicuramente mancava molto. Non era un posto accogliente. E la situazione è cambiata, non solo grazie ai risultati sportivi, ma anche grazie alla qualità istituzionale che si è costruita. E questa qualità deriva dalle persone: la dirigenza, i dipendenti, chi apre le porte ogni giorno. Ecco perché vuoi sempre tornare.
A proposito di istituzionalismo, Pacha Pachamé mi ha raccontato che la squadra di tuo padre aveva nove o dieci studenti universitari: Madero, Bilardo, Manera, Echecopar... e che la differenza stava nell'istruzione. Oggi stai promuovendo un progetto educativo all'interno del club.
Nell'ultima squadra vincitrice della Copa Libertadores, su una cinquantina di giocatori, quasi trenta hanno terminato le scuole superiori nel club. Non è un caso. Abbiamo un liceo adattato alle esigenze dei ragazzi che giocano da dieci anni. Il calcio occupa tutta la loro mente; è il loro sogno. Ma dobbiamo anche insegnare loro che studiare non è un peso, ma uno strumento.
Molti si allenavano, mangiavano in fretta, correvano a scuola e finivano per abbandonare. Così abbiamo creato una scuola che li sostiene, che li capisce. Se non passano le materie, non giocano, e non è una punizione: è una lezione. Oggi i ragazzi lo capiscono. E quando finiscono, fanno fatica a continuare a studiare, ed è per questo che abbiamo aperto una scuola superiore e ora abbiamo un'università, adattata allo sport. Non solo per i calciatori, ma come progetto educativo più ampio.
- L'istruzione come strumento di uguaglianza sociale, come contenimento.
Esatto. L'ho sentito dire molte volte al club. Il principe Sosa, per esempio, ha detto che lo hanno aiutato molto quando era bambino. E queste cose lasciano il segno. Supportare dal punto di vista umano significa anche far crescere i giocatori.
-Una cosa che hai detto mi è rimasta impressa: "Su mille che vedi correre, tre finiscono". Come gestisci la frustrazione di chi fa tutto bene e non finisce?
Molte persone fanno tutto bene: si alzano presto, mangiano bene, si riposano, si allenano. Ma il calcio ha un elemento casuale. È il momento giusto: l'allenatore ti vede, l'opportunità che si presenta. Puoi fare tutto bene e non farcela. Ecco perché il calcio dovrebbe essere uno strumento, non un fine. È un sogno bellissimo, ma anche crudele.
-Rinunci a molte cose per quel sogno.
I bambini iniziano molto presto. Molti provengono dall'entroterra, alcuni anche a dodici anni, per vivere in collegio. Se ci pensi come genitore, sentire il proprio figlio dodicenne dire "Me ne vado" è incredibilmente difficile. E la maggior parte non ce la fa. Ecco perché cerchiamo di sostenerli, di mostrare loro altre opzioni e, soprattutto, di dire loro la verità. Se sai che non succederà, non dire che succederà. Devi prenderti cura di loro, essere onesto e aiutarli.
-Anche l'istruzione aiuta a elaborare tutto questo.
Certo. Inoltre, il calcio è ancora permeato di machismo: "Non puoi piangere", "Non mostrare le tue emozioni". È repressivo. Ci sono ragazzi che giocano perché il padre li pressa, non perché lo vogliano. E si vede. Ho visto ragazzi che hanno smesso, che poi hanno continuato a dedicarsi al cinema, alla scrittura o allo studio, ed erano felici. Alcuni sono persino tornati al club con altri ruoli. Anche questo è successo.
-Nel tuo caso, essere "il figlio della strega Verón" era un peso? E tuo figlio?
Deian aveva il doppio della pressione. Ai miei tempi, non esistevano i social media. Non sapevi chi stava dicendo cosa. Oggi, i ragazzi vivono con questo peso sulle spalle e sono più sensibili. Ho sentito Di María dire che le opinioni lo influenzavano. Ho sentito il peso del nome solo quando ero un professionista, quando ho visto i giornali parlare del "figlio della Strega".
-E da quanto tempo sei leader?
Dal 2014.
-Sei stato sottovalutato perché venivi dal calcio?
Sì, anche all'interno dell'Estudiantes.
-Dove hai imparato a gestire la situazione come fai oggi?
Dai luoghi in cui ho giocato. Ho imparato molto al Manchester e all'Inter. Erano club con strutture impressionanti e mi sono serviti da riferimento per pensare a cosa desiderassi per il mio. Ho anche fatto affidamento su persone che rispetto molto: Pepe Sánchez, Agustín Pichot e Mariano Bessone. Quando ho preso la guida dell'Estudiantes, lo stadio aveva debiti enormi. Ho aperto il cassetto della mia scrivania e c'erano sette assegni firmati. Ho dovuto mettere da parte i miei pensieri e occuparmi delle questioni urgenti. Col tempo, sono stato in grado di ripensare al club che volevo costruire.
-Quanto influenza la passione il processo decisionale?
All'inizio, molto. La mia transizione dal campo alla scrivania è stata molto breve, e questo ha il suo prezzo. Col tempo, impari a trovare l'equilibrio. Capisci quanto sia difficile prendere decisioni con la testa quando tutto intorno a te richiede decisioni che partono dal cuore.
-Se l'Estudiantes fosse quotata in borsa, come concilieresti passione e gestione privata?
Credo che possano coesistere. Gli investimenti privati non uccidono la passione. L'equilibrio è fondamentale. Non credo che chi investe non senta nulla. Al contrario, può dare impulso alla crescita del club. L'Argentina potrebbe avere un sistema unico in cui l'aspetto sociale e quello imprenditoriale coesistono. Ma è complesso, perché qui viviamo sempre al limite.
-Come immagini il club tra dieci anni?
Completamente diverso. Con più infrastrutture, un'università funzionante, capitali privati che contribuiscono senza stravolgerne l'essenza. E, chissà, un club quotato in borsa. Ma sempre con le sue radici sociali intatte: il club come spazio di appartenenza, studio, lavoro, sport e comunità.
-Nella tua esperienza, cosa hai imparato come leader?
L'errore più grande è sottovalutare le situazioni. Devi circondarti di persone che ne sanno più di te. L'ego ti tradisce. Devi avere visione, spirito di squadra e coraggio. Tutto qui.
-Hai deciso di creare il marchio di abbigliamento del club. Come è nata questa idea?
Ci stavamo pensando da un po'. Ci siamo resi conto che i marchi non investevano e che il rapporto era instabile. Ci siamo detti: "Tra il non guadagnare nulla dagli altri e il non guadagnare nulla da noi stessi, facciamolo da soli". E lo abbiamo fatto. All'inizio, è stato un percorso di tentativi ed errori: materiali, logistica, tutto. Ma ha avuto un'ottima risposta. Oggi è il progetto di punta del club.
-Quali sono le principali fonti di reddito oggi?
Prima la vendita dei giocatori. Poi le quote associative. Infine la pubblicità, i marchi e la televisione.
-Ci sono molti giovani in campo.
Sì, abbiamo fatto uno studio: il 40% degli iscritti ha meno di 40 anni. C'è un futuro. E dobbiamo lavorare per aumentarlo. Ma i tempi sono cambiati. Oggi è più difficile costruire relazioni, c'è meno dialogo faccia a faccia, più tempo davanti allo schermo. Nel calcio, dove bisogna costruire empatia e conoscere gli altri, questo si sente.
-E come gestisci la pressione per vendere i giocatori?
Fa parte del progetto istituzionale. Se ci sono giovani giocatori di talento, devono giocare, perché questo sostiene le finanze del club. Ma non è imposto. Lavoriamo insieme all'allenatore.
-Oggi gli allenatori hanno più influenza rispetto al passato.
Molto di più. Prima si parlava del Milan di Sacchi; oggi si parla di Guardiola prima del Manchester City. Tutto è cambiato. Prima si facevano allenamenti di dieci giorni in precampionato senza toccare palla. Oggi l'allenamento è segmentato, più breve, più analitico. La preparazione è tutta un'altra storia.
- Ai suoi tempi, le scuole pubbliche erano equilibrate. Oggi, il divario sociale è enorme. Che impatto ha su di lei?
È un problema serio. Il calcio richiede intelligenza, comprensione e rapidità di pensiero. Prima, bastava coprire il proprio territorio. Oggi, il gioco richiede di pensare di più. E i ragazzi arrivano con molta pressione: problemi familiari, problemi finanziari. Ecco perché nelle squadre giovanili ci sono grandi staff tecnici, psicologi, assistenti, allenatori, neuroscienziati. Cerchiamo di supportarli da ogni punto di vista.
-I ragazzi di oggi affrontano problemi diversi: gioco d'azzardo, ansia, social media. Cosa diresti ai genitori?
Lasciateli essere felici. Non fate loro pressione. I bambini soffrono per lo sradicamento, l'ansia, le pretese. Sentono di dover avere successo per non deludere. E questo li opprime. Alcuni si arrendono per questo. Bisogna sostenerli, non imporglielo.
-Sei molto impegnato nei confronti della comunità.
Oggi i club svolgono il ruolo che un tempo ricoprivano le scuole pubbliche. Sono spazi dedicati all'educazione, all'alimentazione, alla psicologia e al supporto. In passato, l'aula era occupata dal figlio del medico e dal figlio dell'operaio. Questo ruolo è andato perduto, e il club lo mantiene. Ecco perché abbiamo l'obbligo di occupare quel posto e rafforzarlo.
"È stato un piacere parlare con te. Ti ho visto emozionarti così tante volte; dedica questo momento a Ruso Prátola."
Era un grande amico... ed è sempre lì.
lanacion