Creare lettori veri, contro l’illusionismo creativo delle scuole di scrittura

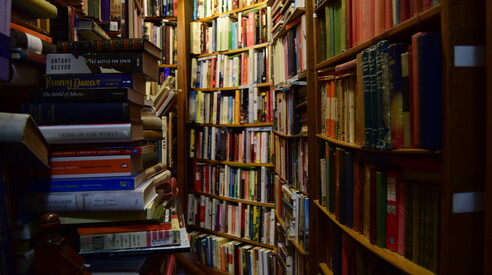
Foto di Rudy Issa su Unsplash
Contro il declino della lettura e dei lettori competenti, la letteratura rischia di svuotarsi di senso. Solo chi legge davvero può generare buona scrittura: il resto è illusione da bestseller o da laboratorio
Sullo stesso argomento:
Dove sei lettore? E’ questo il titolo di un lungo articolo che pubblicai sette anni fa su questo giornale. Non l’ho riletto, ma se sento il bisogno di mettere in scena lo stesso interrogativo di allora è perché il cosiddetto trend negativo resta lo stesso: i lettori diminuiscono sia per numero che per qualità e competenza. Neppure i giornali vengono risparmiati dal tramonto del lettore e della lettura. Le edicole spariscono implacabilmente, le librerie chiudono o sono vuote e si salvano quasi soltanto quelle Feltrinelli. Come mito, idolo o feticcio il libro sopravvive: ma solo a condizione che si tratti di un bestseller di recentissima pubblicazione. Una volta entrare in libreria voleva dire esplorare scaffali nascosti nei quali si potevano trovare anche libri usciti dieci e più anni prima. Ora succede che non ci si trovi neppure un libro di sei mesi fa.
Ma chi va più a cercare libri in libreria? Solo chi è certo di trovarci qualcosa di pubblicizzato sui giornali a tutta pagina con gigantografia dell’autore, quasi sempre un divo televisivo. Così di solito fa il lettore-non lettore, quello che aspetta le vacanze estive per leggere qualcosa. Sembra che durante l’anno nessuno trovi più il tempo per aprire un libro, anche se di tutte le innovazioni tecnologiche si dice che ci faranno risparmiare tempo, da usare per consumare cultura. Il massimo che ci si può aspettare dal lettore estivo è che si decida ad aprire con mano tremante un famoso classico che si sarebbe dovuto leggere fra i venti e i quarant’anni per “formare il carattere”, come Il rosso e il nero, Madame Bovary o Delitto e castigo. Ma chi non lo ha fatto prima a tempo debito difficilmente si metterà a leggere davvero quelli che ormai sono più titoli da nominare che opere a cui dedicare almeno mezz’ora al giorno: meglio evitare quei pesanti “mattoni”!
D’altra parte succede spesso che anche le persone colte, i laureati, i professionisti, e perfino gli studiosi e i docenti di letteratura, non abbiano letto i venti maggiori classici della narrativa, della poesia e del pensiero moderno. Poi è chiaro che ognuno di noi ha le lacune di cui vergognarsi: io per esempio non ho letto Moll Flanders, né Il mulino sulla Floss, né sono arrivato all’ultima pagina della Recherche (ho letto solo quella) e dell’Uomo senza qualità, per non parlare della Gerusalemme liberata. In compenso (se è un compenso) mi è capitato di leggere da giovane la Bhagavadgita e Passato e pensieri di Herzen, un capolavoro politico e letterario che nessun politico e nessun letterato conosce. I libri di poesia, poi, chi li legge? Io di poesia ne ho letta e riletta anche troppa, e tuttora ne assaggio qualcosa quasi tutti i giorni per ammirare l’arte della concentrazione e del ritmo. Ma chi scrive ha il diritto anche di leggere poco, ripetutamente, e per i suoi scopi personali. A chi scrive brevi prose di pensiero consiglio due autori che ho scoperto abbastanza tardi e che conoscono a malapena perfino i germanisti e gli anglisti, cioè Lichtenberg e Hazlitt.
Ma qui mi fermo, perché se si comincia a parlare di lettori e lettura non si finisce più. In realtà mi sono messo a scrivere questo articoletto per uno scopo preciso e limitato: per dire cioè che la qualità dei libri che si pubblicano peggiora nella misura in cui diminuiscono i lettori competenti e la qualità della lettura. La novità arrivata negli ultimi decenni è che neppure i critici e gli studiosi sono più capaci di capire una poesia o un romanzo, né riescono a riconoscere il valore letterario di uno stile saggistico. Si sta diffondendo una specie di informatica umanistica postumana, figlia del metodologismo degli studi letterari anni Sessanta e Settanta, quando studiare non voleva più dire leggere bene, ma applicare ai testi letterari schemi strutturalistici, semiologici o freudiani prefabbricati e presuntamente scientifici. Così già mezzo secolo fa si scavalcò la lettura intensificata praticata da grandi critici come Leo Spitzer, Erich Auerbach e George Steiner per fare scienza e teoria della letteratura.
Oggi la memoria mentale del filologo e del critico è sostituita da una memoria digitale. Perciò da un lato c’è la lettura turistica da consumo culturale, dall’altro c’è la non lettura scientifica e professionale, metodologistica o computistica. In tutti e due i casi il testo letterario non è percepito come una “presenza reale” (così diceva Steiner) ma come un pretesto per lavorare e “fare ricerca”, o come pura occasione di svago momentaneo. Credo che un essenziale compito educativo sia oggi formare, creare lettori, veri lettori competenti, contro l’illusionismo creativo delle scuole di scrittura. Se sottovalutiamo l’atto di leggere, tutta la nostra cultura è in pericolo. E’ in pericolo la sua tradizione e il potere della sua “passività creativa”. Se il lettore non sa leggere o legge male, anche i testi scritti perderanno almeno in parte significato e valore. Sono i cattivi lettori quelli che incoraggiano a scrivere i cattivi scrittori. Una migliore letteratura può nascere solo da lettori migliori.
Di più su questi argomenti:
ilmanifesto





