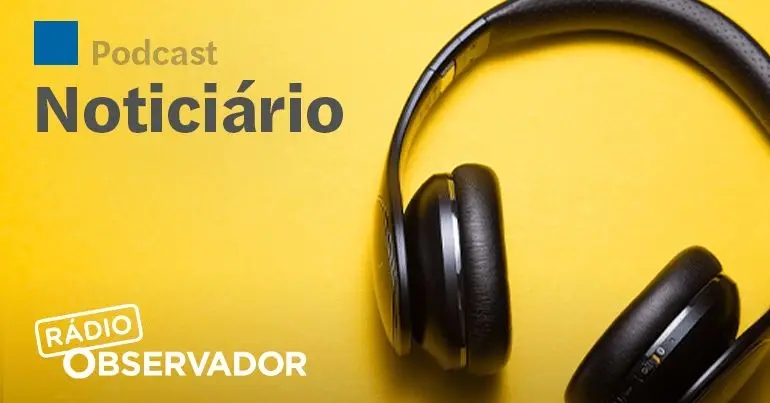Prepararsi alla pace? Lezioni dall'antichità in un'Europa incerta

Per decenni, molti europei hanno dato per scontate la pace e la sicurezza. Tuttavia, i recenti sviluppi geopolitici ci hanno ricordato che la pace, oltre a essere preziosa, è anche profondamente precaria. Le minacce di guerra non sono più confinate a continenti lontani, né tantomeno ai confini europei. I nuovi e ingenti investimenti nella difesa militare riflettono una realtà preoccupante, mentre il vecchio adagio latino si vis pacem, para bellum – "se vuoi la pace, preparati alla guerra" – viene nuovamente preso alla lettera e considerato un principio essenziale.
In un certo senso, i dilemmi del nostro tempo e le recenti disillusioni sembrano rispecchiare idee già dibattute dagli autori dei primi secoli dell'Impero romano. Quest'epoca, così spesso idealizzata dalla sua Pax Romana , iniziò quando il primo imperatore, Augusto, uscì vittorioso dalle guerre civili che avevano dilaniato la Repubblica romana, sconfiggendo Marco Antonio e Cleopatra ad Azio nel 31 a.C. Da allora in poi, proclamò una nuova era di stabilità e prosperità. Questa "pace", che durò per due secoli fino alla morte di Marco Aurelio nel 180 d.C., fu ampiamente celebrata in tutto l'impero, anche se le legioni romane continuavano a combattere ai suoi confini, da Nord a Sud e da Ovest a Est. L'illusione di una pace duratura nascondeva quindi tensioni latenti.
Gli intellettuali dell'epoca riflettevano spesso sul concetto di Pax Romana e molti esaltavano questo stato apparentemente benedetto nelle loro opere letterarie. Ma questo elogio non significava che ne ignorassero le contraddizioni. Al contrario, si interrogavano seriamente su cosa fosse veramente la pace e su come potesse essere preservata per le generazioni future. Una delle principali risorse di questo discorso pacifista era l'uso di exempla : storie di personaggi illustri del passato, intese a istruire i lettori sulla complessità del comportamento umano, evidenziandone sia le virtù che i vizi.
Talvolta, questi autori si rivolgevano direttamente agli imperatori stessi, nel tentativo di influenzarne le decisioni e guidarli verso il mantenimento di questa fragile pace. Il filosofo e biografo greco Plutarco di Cheronea, ad esempio, raccolse circa cinquecento aneddoti nell'opera "Detti di re e generali ", dedicata all'imperatore Traiano intorno al 117 d.C., ultimo anno del suo regno espansionistico. Analisi recenti suggeriscono che, attraverso questi exempla , Plutarco abbia cercato di incoraggiare l'imperatore a dare priorità alla stabilità interna dell'impero, seguendo l'esempio del "pacificatore" Augusto.
Ironia della sorte: molti degli eroi ritratti da Plutarco e dai suoi contemporanei parteciparono attivamente alle guerre, spesso come comandanti. Ciò non sorprende, poiché i conflitti tendono a essere teatro di azioni straordinarie e complessi dilemmi etici. Tuttavia, le sanguinose dinamiche del passato greco-romano insegnarono agli scrittori del I e del II secolo che il sogno di una Pax Romana perpetua poteva essere di per sé un'illusione. La pace non doveva essere data per scontata. Il fatto che rivisitassero ripetutamente gli orrori e i traumi delle generazioni precedenti rivela una profonda consapevolezza della propria fragilità.
Oggi, di fronte a una nuova ondata di insicurezza, la tradizione classica non ci offre né risposte dirette né soluzioni facili. Ma ci ricorda che la pace richiede uno sforzo continuo e il coraggio di imparare dal passato. Proprio come gli intellettuali romani cercavano di plasmare il loro futuro riflettendo sui conflitti precedenti, anche noi dobbiamo continuare a rivisitare la storia, non per glorificare la guerra, ma per rinviare, prevenire o mitigare ciò che a volte può sembrare inevitabile.
Laurens van der Wiel, ricercatore post-dottorato presso l'Università di Varsavia, e Wim Nijs, ricercatore post-dottorato presso l'Università di Toronto e relatori alla Conferenza Celtica sui Classici
sapo