Mi è stato diagnosticato un cancro incurabile. Questa cura futuristica potrebbe salvarmi.

Nell'autunno del 2003, una sera, mentre uscivo dal mio ufficio, sono scivolato sul ghiaccio. L'anca mi ha fatto male per un anno, ma per lo più l'ho ignorata. Quando il dolore non è passato, sono andato dal mio medico, che mi ha prescritto una risonanza magnetica. Sono andato nel suo studio e mi ha detto che avevo un tumore all'anca. Avevo 38 anni, intraprendevo una promettente carriera nel giornalismo, ero sposato con una donna che amavo e diventavo padre per la prima volta di una bambina di sette mesi.
Quando mi è stato diagnosticato il tipo di cancro che poi ho, una forma rara e incurabile di tumore del sangue chiamato mieloma multiplo, mi è stato detto che avevo diciotto mesi di vita. Sono passati più di ventuno anni.
In questi ventuno anni, mi sono sottoposto a una raffica di trattamenti per combattere la mia malattia. Tra questi, quattro cicli di radioterapia (ad anca, collo, costole e naso); un ciclo di immunoterapia endovenosa settimanale di sei mesi (seguito da sette anni di terapia di mantenimento sotto forma di pillola); un altro ciclo di immunoterapia di due anni con le versioni di nuova generazione dei farmaci che assumevo in precedenza, sotto forma di pillola; un terzo ciclo di immunoterapia con due nuovi farmaci immunoterapici somministrati settimanalmente per via endovenosa per altri due anni; e sei anni (e il conteggio continua) di infusioni endovenose mensili di un agente usato per rafforzare il mio sistema immunitario, compromesso sia dalla mia malattia che dai trattamenti utilizzati per combatterla. Ma il trattamento più straordinario che ho ricevuto finora è una procedura all'avanguardia, approvata dalla FDA per l'uso in casi come il mio solo nel 2022, chiamata terapia CAR-T. Questa è la storia di quel trattamento.
Questa volta non sono scivolato sul ghiaccio. Mi sono chinato per caricare la lavastoviglie e ho sentito una fitta di dolore alla schiena. Era febbraio del 2023. Il mio oncologo, il dottor Sundar Jagannath del Mount Sinai Hospital di New York, mi ha prescritto una serie di esami del sangue e scansioni. Hanno dimostrato che ero uscito dalla remissione, per la settima volta. Avevo tumori all'anca, alle costole e alla colonna toracica e lombare.
In una giornata di marzo stranamente bella, io e mia moglie Didi abbiamo incontrato il Dott. Jagannath. La mia migliore opzione terapeutica, mi ha spiegato, era un tipo di immunoterapia praticamente nuova, all'avanguardia, quasi incredibilmente futuristica, chiamata terapia CAR-T. Sarebbe stato il trattamento più potente e pericoloso che avessi mai provato fino ad allora.
La terapia CAR-T prevede il prelievo di linfociti T dal flusso sanguigno e il loro invio in laboratorio, dove una proteina chiamata recettore chimerico per l'antigene, o CAR, viene aggiunta alla superficie dei linfociti T (da cui l'acronimo "CAR-T"). La proteina CAR aiuta i linfociti T a riconoscere gli antigeni presenti sulla superficie di specifiche cellule tumorali, nel mio caso cellule di mieloma, in modo che possano colpire e distruggere le cellule maligne. I linfociti T caricati con il CAR vengono quindi reinfusi per via endovenosa nel corpo per svolgere la loro funzione.

Quando ho iniziato la terapia CAR-T, io e mia moglie Didi avevamo decine di domande.
La CAR-T è una cosiddetta terapia "one-and-done"; richiede poche cure di mantenimento, ha spiegato. Se funzionasse, potrei tornare a vivere una vita relativamente normale, almeno per un certo periodo, con poca o nessuna terapia di mantenimento richiesta.
Naturalmente, c'erano delle riserve. Il CAR-T non è affatto efficace al 100%, richiede mesi di preparazione, alcuni dei quali complessi e spiacevoli, e ha una serie di effetti collaterali potenzialmente debilitanti e talvolta fatali.
La definizione scientifica di "chimera" – la parola chiave nel contesto del recettore antigenico chimerico – è una parte del corpo composta da tessuti con materiale genetico eterogeneo, ma il termine ha altri due significati. Uno è un mostro immaginario composto da parti incongrue. L'altro è un'illusione, più specificamente un sogno irrealizzabile. Entrambi sembravano appropriati.
Poiché la CAR-T è una terapia complessa e altamente specializzata, il Dott. Jagannath mi ha indirizzato a uno specialista in CAR-T per la gestione del mio trattamento. Didi e io abbiamo avuto il nostro primo appuntamento con il Dott. Shambavi Richard diverse settimane dopo.
La Dott.ssa Richard è una donna indo-americana dai lunghi capelli neri che ama portare occhiali alla moda. Essa riesce a conciliare un atteggiamento amichevole e disinvolto con una profonda competenza professionale.
La preparazione del CAR-T, mi spiegò, era davvero complessa. Nel mio caso, avrebbe incluso decine di esami del sangue; una biopsia ossea e una biopsia del midollo osseo; una procedura per prelevare i miei linfociti T; possibilmente ulteriore radioterapia se i tumori alle ossa fossero diventati problematici prima di ricevere il CAR-T (ci vuole circa un mese dopo il prelievo dei linfociti T perché le cellule potenziate vengano prodotte); un ricovero ospedaliero di quattro giorni per la somministrazione di un regime chemioterapico noto come DCEP, volto a ridurre il numero di cellule mielomatose nell'organismo e rendere il trattamento CAR-T più efficace; tre giorni di un trattamento ambulatoriale chiamato linfodeplezione, un'altra forma di chemioterapia, che uccide i linfociti T esistenti per aiutare i linfociti T bioingegnerizzati ad attaccare le cellule mielomatose in modo più efficace; e il posizionamento di un catetere nel torace che sarebbe stato utilizzato per infondere i linfociti CAR-T, somministrare farmaci correlati e prelevare sangue per monitorare la mia emocromo durante le due settimane di degenza ospedaliera richieste dall'infusione di CAR-T.
I due effetti collaterali più gravi della terapia CAR-T, ci ha spiegato, sono la sindrome da rilascio di citochine e la neurotossicità. La sindrome da rilascio di citochine, o CRS, si verifica quando il sistema immunitario dell'organismo risponde in modo troppo aggressivo a un'infezione. Nel caso della terapia CAR-T, l'organismo sembra scambiare le cellule bioingegnerizzate per un'infezione, innescando la risposta indesiderata. I sintomi della CRS includono febbre e brividi ("shake and bake", come la chiamano alcuni medici), affaticamento, diarrea, nausea e vomito, mal di testa, tosse e ipotensione. Se non trattata tempestivamente, la condizione può essere fatale.
Neurotossicità è un termine generico che si riferisce a un insieme di sintomi neurologici che possono includere mal di testa, confusione, delirio, difficoltà di linguaggio o incoerenze, convulsioni ed edema cerebrale, ovvero gonfiore del cervello. Anch'esso può essere mortale se non trattato immediatamente.
La terapia CAR-T lascia inoltre i pazienti gravemente immunodepressi e vulnerabili alle infezioni per mesi e a volte anni dopo. Distrugge il loro sistema immunitario a tal punto che alla fine devono sottoporsi a tutte le vaccinazioni infantili (parotite, morbillo, rosolia, ecc.), per non parlare di quelle contro COVID e antinfluenzali. Finché non ricevono queste vaccinazioni, che non possono essere effettuate prima di sei mesi dalla terapia CAR-T, sono vulnerabili a tutte queste malattie e ad altre ancora. Durante i miei ricoveri in ospedale, mi era consentito ricevere solo un numero limitato di visitatori, e tutti dovevano indossare la mascherina. Una volta tornato a casa, avrei dovuto adottare comportamenti più prudenti di quanto avessi fatto all'inizio del COVID.

Mi è stato diagnosticato il mieloma a 38 anni, quando ero appena diventato padre.
Io e Didi avevamo decine di domande. Aspetta, come funziona di nuovo la terapia CAR-T? Il prelievo di cellule T avrebbe causato lo stesso formicolio da formica di fuoco che mi aveva causato il prelievo di cellule staminali? Avrei potuto partecipare al matrimonio di mia nipote a Cape Cod ad agosto?
Oltre a essere un medico di fama mondiale, la Dott.ssa Richard è una persona di ascolto di prim'ordine. Ha risposto pazientemente a tutte le nostre domande, ci ha detto che il suo studio avrebbe fissato gli appuntamenti necessari e ci ha congedato.
Io e Didi prendemmo un taxi per tornare a casa. Mentre percorrevamo la Quinta Strada, ci sentivamo stranamente ottimisti. Agire è meglio che non agire. E io sarei diventata bionica.
Ho fatto gli esami del sangue. Ho fatto le biopsie. Ho fatto il prelievo dei linfociti T. Non ho dovuto sottopormi a radioterapia.
Per prepararmi alla perdita dei capelli durante i due cicli di chemioterapia, mi sono fatta tagliare i capelli a zero. Mi sembrava che perdere ciocche corte sarebbe stato meno traumatico che perdere ciocche lunghe. Quando il mio barbiere mi ha fatto notare che per me era una scelta drastica, ho mentito e ho detto che volevo stare al fresco per l'estate. Poi, giovedì 11 maggio, mi sono registrata al Mount Sinai per iniziare il mio trattamento DCEP di quattro giorni.
"DCEP" è un acronimo generico di "Desametasone, Ciclofosfamide, Etoposide e Cisplatino", i quattro farmaci che compongono il regime terapeutico. Vengono somministrati per via endovenosa. Alle quattro di quel pomeriggio, ero sistemato nella mia stanza all'undicesimo piano dell'ospedale, attaccato a un'asta per flebo.
Poiché il DCEP deve essere somministrato ininterrottamente, ero attaccato alla mia flebo 24 ore su 24. Sono stato attaccato a molte flebo e sono qui per dirvi che le pompe elettroniche utilizzate per somministrarle sono difettose. La parte più fastidiosa è che gli allarmi di cui sono dotati i dispositivi, che dovrebbero attivarsi solo in caso di problemi con il flusso del farmaco, spesso si attivano senza motivo. Ogni volta che succede, un'infermiera deve venire, controllare che tutto sia a posto e resettare la pompa. Quando si è attaccati alla pompa 24 ore su 24, questo può essere esasperante. Di certo non favorisce il sonno.
Dopo quattro giorni in ospedale, non vedevo l'ora di tornare a casa. Fisicamente mi sentivo bene. Per fortuna, avevo tollerato il DCEP praticamente senza effetti collaterali. Ma mi sentivo esausta per non aver dormito molto ed emotivamente esausta.
Il quarto giorno, subito dopo cena, mi hanno dimesso.
La mattina dopo, dopo che mio figlio Oscar era andato a scuola, mi sono seduta sul divano in soggiorno. Didi era al tavolo della sala da pranzo, a lavorare al suo portatile.
"Sai cosa è bello?" dissi.
Da quando ero partito per l'ospedale fino a quel momento, non mi ero mai sentito particolarmente spaventato o turbato. Per lo più, per le novantasei ore trascorse al Mount Sinai, avevo semplicemente abbassato la testa e fatto quello che dovevo fare.
Ho iniziato a rispondere alla mia domanda. Quello che intendevo dire era: "Dormire nel tuo letto". Ma prima che potessi finire la frase, tutte le emozioni che avevo apparentemente represso nei precedenti quattro giorni in ospedale, o forse nei precedenti diciannove anni, sono riemerse in superficie.

Nonostante il successo della terapia, ho ancora paura di lasciare mio figlio Oscar e mia figlia AJ senza un padre.
Sono una persona relativamente stoica. Non mi lascio facilmente sopraffare dai miei problemi. Non sono nemmeno particolarmente incline a parlarne.
Beh, il cancro rende bugiardi gli stoici. Proprio come attacca il tuo corpo, attacca le tue difese emotive, e non si ferma finché non te le ha strappate via. Vuoi combattere per diciannove anni? Va bene. Il cancro è paziente. Il cancro aspetterà. Ride della tua perseveranza. Si fa beffe del tuo labbro superiore rigido. È divertito dal tuo coraggio. Alla fine, ti spezzerà. Puoi entrare nel cancro da stoico, ma non uscirai da stoico.
Ho iniziato a piangere. A piangere a dirotto, davvero. Un lamento profondo, primordiale, orribile. Era la prima volta che piangevo così forte da quando mi avevano diagnosticato la malattia. Contrariamente al mio stoico istinto, piangere non mi faceva sentire debole o in imbarazzo. Mi faceva sentire sollevata. Era come se diciannove anni di peso mi fossero stati tolti dalle spalle.
"Mi siete mancati così tanto, ragazzi", riuscii a dire a Didi tra un respiro affannoso e l'altro. "Sono così felice di essere a casa."
Mi è stato chiesto se ho paura di morire. La risposta è no, non proprio. Dopo essere stato costretto a riflettere a lungo e intensamente sull'argomento, ci ho fatto i conti. Per me, la morte è morte. Non c'è paradiso né inferno. Solo cibo per vermi. Il nulla. Perché dovrei aver paura di niente?
Ciò di cui ho paura è la sofferenza. Ho visto la sofferenza da vicino, negli studi degli oncologi, nelle strutture di cura e nei reparti di oncologia. È decisamente spaventoso.
Durante i miei trattamenti di radioterapia, ho visto pazienti con ustioni cutanee così gravi da sembrare vittime di incendi dolosi. Durante le mie sedute di trattamento, ho visto un signore bagnarsi i pantaloni sulla sedia mentre dormiva; una donna collassare mentre andava in bagno, spaccarsi la testa e sanguinare dappertutto sul pavimento; e water coperti di schizzi di diarrea. Durante i miei ricoveri in ospedale, ho visto pazienti calvi, emaciati e pallidi come le coperte bianche dell'ospedale in cui erano avvolti per tenerli al caldo. Ho sentito lamenti, urla e suoni che francamente non so come descrivere. I reparti di oncologia sono stati definiti case dell'orrore. Vorrei poter contestare questa descrizione.
Ho ancora paura di lasciare Oscar e mia figlia AJ senza un padre. Non perché non creda che staranno bene. Ho una fiducia incrollabile in loro. Ma se c'è qualcosa di innato nei genitori della specie umana, è il dovere di provvedere alla propria prole. Non essere in grado di farlo, anche se questa incapacità è al di fuori del mio controllo, sarebbe, per me, un fallimento imperdonabile.
Vorrei anche vedere AJ e Oscar crescere, iniziare la loro carriera, sposarsi e avere figli, se lo desiderano. Vorrei trascorrere la pensione con Didi, scrivere di più, pescare di più, giocare di più a poker e fare più viaggi con la famiglia e gli amici.
Non ho paura di essere morto. Ho paura di non essere vivo.
Il DCEP avrebbe dovuto essere un leone. Fisicamente, almeno, era un agnello. La linfodeplezione avrebbe dovuto essere un agnello. Si è scoperto che aveva un morso.
I miei trattamenti erano programmati per giovedì, venerdì e sabato. La domenica era un giorno di riposo. Lunedì sarei stata ricoverata in ospedale per la mia CAR-T.
Come la DCEP, la linfodeplezione viene somministrata per via endovenosa, ma in regime ambulatoriale. Dopo la prima infusione, mi sentivo bene. Dopo la seconda, mi sentivo uno schifo. Dopo la terza, mi sentivo peggio di qualsiasi trattamento oncologico a cui mi fossi sottoposto. Avevo nausea, vertigini e una debolezza tale che riuscivo a malapena a bere un bicchiere d'acqua o ad alzarmi dal letto. Dovevo strisciare a quattro zampe per andare in bagno.
Nel bene o nel male, gli esseri umani tendono a considerare una folta chioma un segno di buona salute e la perdita dei capelli un segno rivelatore di cancro. Io ho sempre avuto una bella chioma. Da adulta, ho sempre avuto la tendenza a portarli lunghi sopra e corti ai lati, con una ciocca che mi pendeva sulla fronte. Didi li chiama i miei riccioli da Superman.
Sebbene i miei capelli avessero iniziato a cadere un po' durante il DCEP, ora cadevano completamente. Quando ho fatto la doccia, la schiuma di shampoo che avevo tra le mani era punteggiata da migliaia di piccoli pezzetti di barba nera e grigia.
Fu più sconvolgente di quanto pensassi. Il mio tentativo di prevenire quella sensazione tagliandomi i capelli a zero non funzionò: ci sono cose a cui non ci si può preparare. Dopo quasi vent'anni, avevo finalmente sperimentato forse l'effetto collaterale più familiare del cancro. Perdere i capelli era un segno inequivocabile e innegabile della mia malattia, e bruciava. Il ricciolo da Superman era sparito.
Dopo l'ultimo trattamento di linfodeplezione, presi un taxi per tornare a casa dall'ospedale. Era sabato 24 giugno 2023, il giorno prima del New York City Pride March, e poiché diverse strade principali erano già state bloccate, il traffico era congestionato. Un tragitto che normalmente avrebbe richiesto quarantacinque minuti era già durato ben più di un'ora, e mi mancavano ancora più di venti isolati.
Mentre avanzavamo lentamente lungo Park Avenue South, un pick-up si fermò accanto al mio taxi. Era un Ford F-150 rosso con targa del New Jersey. L'autista e il passeggero anteriore erano giovani ventenni, in canottiera e cappellini da baseball. I Bon Jovi rimbombavano a tutto volume dagli altoparlanti. Se fossero stati personaggi di un film, li avreste liquidati come troppo sfacciati.

Per prepararmi alla perdita dei capelli durante i due cicli di chemioterapia, mi sono fatta tagliare i capelli a zero.
Come capita quando il sistema immunitario è a pezzi in preparazione di una futuristica terapia contro il cancro, indossavo una mascherina sul sedile posteriore del taxi e avevo il finestrino abbassato. Anche l'autista del pick-up, che ora si trovava a non più di un metro da me nella corsia alla mia destra, aveva il finestrino aperto. Prima ancora che aprisse bocca, sapevo già cosa avrebbe detto.
La frase esatta era: "Amico, togliti la maschera". Il suo gregario rise.
In famiglia, ci piace raccontare una storia su mio padre. Quando avevo forse cinque anni, tutti e sei, mio padre, mia madre, i miei tre fratelli e io, eravamo a sciare nella parte settentrionale dello stato di New York. Era una giornata particolarmente affollata e c'era una lunga fila per uno degli impianti di risalita.
Quando un gruppo di adolescenti cercò di passare davanti a tutti, mio padre, che era notoriamente un'anima gentile ma anche una persona che credeva nelle regole, li sgridò.
"Scusate, ragazzi", disse. "Siamo qui ad aspettare da un sacco di tempo. Dovete andare in fondo alla fila."
I ragazzi lo ignorarono.
"Ragazzi, andate dietro."
Niente.
"Ragazzi …"
E poi: "Vaffanculo, vecchio".
Fu tutto. Qualcosa dentro mio padre, di solito mite, scattò. Sfilò gli scarponi dagli sci, si avvicinò ai bambini e afferrò il capobranco per i risvolti del cappotto.
"Vai dietro", disse. "Ora!"
E tornarono indietro.
Di ritorno sulla Park Avenue South, ho dato sfogo al mio Gene Gluck interiore.
Scesi dal taxi (comunque il traffico era bloccato) e mi avvicinai all'autista del pick-up.
Il mio soliloquio a Midstreet è stato più o meno questo: "Sono un malato di cancro, stronzo. Sto tornando a casa da una seduta di chemioterapia. Lunedì andrò in ospedale per due settimane di un trattamento che potrebbe uccidermi. Indosso una mascherina perché il mio sistema immunitario non funziona. Vaffanculo".
In termini di potenza della mia performance, non ha guastato il fatto che, grazie al DCEP e alla linfodeplezione, non solo avessi perso la maggior parte dei miei capelli, ma fossi anche magra e dall'aspetto cenere.
Per essere onesti, nel momento in cui sono sceso dal taxi, l'autista ha capito cosa stava succedendo e, una volta che ho avuto conferma dei suoi sospetti, è sembrato sinceramente pentito.
"Scusa, amico", disse. "Colpa mia."
Sono risalito in taxi e lui e il suo compagno hanno svoltato a destra all'incrocio successivo, suppongo per evitare di dovermi continuare ad avanzare lentamente accanto.
Di solito non credo nel giocare la carta del cancro. Nella maggior parte dei casi, è uno strumento troppo potente per il lavoro, per non parlare del suo potere manipolativo. Ma quel giorno, ho fatto un'eccezione.
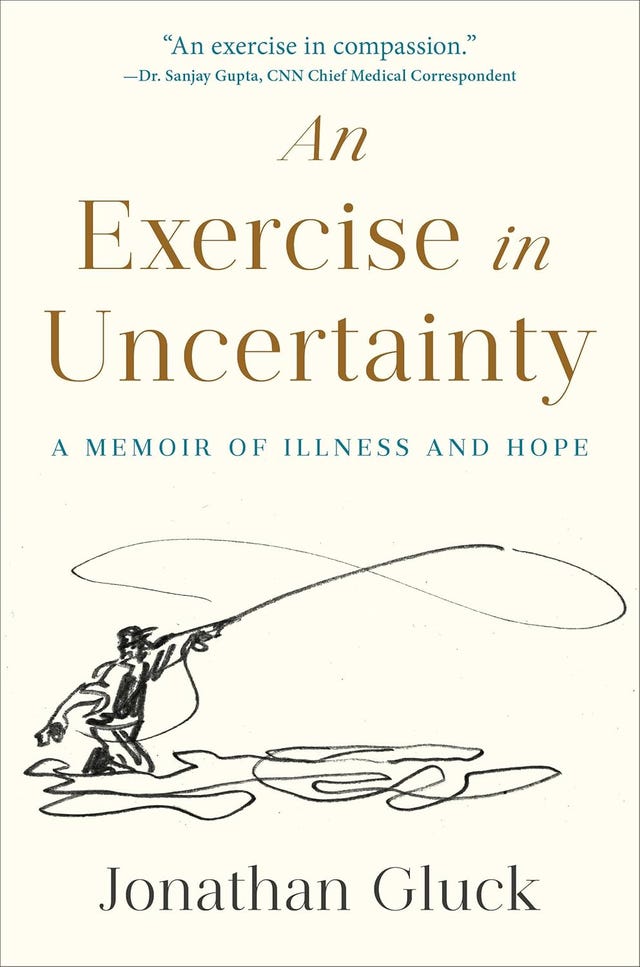
Lunedì 26 giugno sono tornato al Mount Sinai, questa volta per ricevere la terapia CAR-T. Medici e infermieri hanno spiegato a me e a Didi che l'infusione sarebbe stata indolore e avrebbe richiesto solo mezz'ora circa.
Dopodiché, mi avrebbero monitorato attentamente, inizialmente ogni quindici minuti, poi ogni mezz'ora, poi ogni ora e, in seguito, diverse volte al giorno, per individuare eventuali sintomi di CRS e neurotossicità, per tutta la durata della mia degenza ospedaliera di due settimane.
Il monitoraggio della CRS prevedeva esami del sangue e controlli della temperatura e della pressione sanguigna. Lo screening per la neurotossicità prevedeva di chiedermi se conoscevo il mio nome, il giorno, la città in cui mi trovavo e così via, e test di scrittura per monitorare le mie capacità motorie.
Come ci era stato detto in precedenza, mi sarebbe stato consentito solo un numero limitato di visitatori e tutti avrebbero dovuto indossare la mascherina. Ero arrivato con due romanzi, tre libri di cruciverba e i miei abbonamenti a Netflix, Hulu e Peacock. Le mie sorelle e mio fratello mi hanno mandato una foto di noi quattro a un matrimonio di famiglia da tenere sul comodino.
Avevo intenzione di lavorare mentre ero in ospedale. La dottoressa Richard mi ha appoggiato. Mi avrebbe aiutato a distrarmi, ha detto. Per evitare che le riunioni su Zoom risultassero inquietanti, avrei spento la videocamera o avrei personalizzato lo sfondo con qualcosa di diverso da una stanza d'ospedale.
Quando arrivò il momento, una delle infermiere portò dentro un'asta per flebo con la sacca contenente le mie cellule CAR-T appesa. Il liquido nella sacca era incolore e generalmente anonimo, come acqua. Ricordo di essermi chiesto come qualcosa di così straordinario potesse apparire così banale.
Poi l'infermiera prese il catetere di plastica che usciva dalla sacca e lo attaccò al catetere che mi era stato inserito nel torace quel giorno. Vidi le prime gocce penzolare dalla valvola sul fondo della sacca, poi staccarsi e percorrere il catetere fino alle vene.
Didi era seduta accanto al mio letto, sulla sedia dei visitatori.
"Okay, cellule", disse. "Funzionano."
Per i primi giorni di degenza in ospedale, mi sentivo bene. Non che mi stessi divertendo un mondo o qualcosa del genere. I controlli della temperatura, della pressione, i prelievi del sangue e i test sulle funzioni cognitive erano incessanti.
"Hai dolore?"
"NO."
"Adesso ti misuro la pressione."
"Va bene."
"E ora la temperatura."
"Sicuro."
E così via.
Mi sono punto con gli aghi centinaia di volte. Ci sono abituato. Ma essere svegliato ogni notte a mezzanotte e alle 3 del mattino per farmi la puntura era una novità per me.
Fare la doccia era un circolo vizioso. A causa del catetere, non mi era permesso fare una doccia normale perché avrei potuto sviluppare un'infezione, ma a causa del mio sistema immunitario compromesso, dovevo mantenere la pelle pulita per evitare infezioni. La soluzione prescritta era un tipo speciale di salviette disinfettanti, sicure da usare quotidianamente sulla pelle. Posso dire che sono un sostituto poco efficace della doccia.
Per i test cognitivi, uno dei medici o degli infermieri mi chiedeva di scrivere "la mia frase", una copia di una frase che mi avevano fatto scrivere il primo giorno come base di partenza per monitorare le mie capacità motorie fini. La mia frase era: "Oggi ho fatto colazione, ho guardato la TV, ho letto un libro e ho fatto una passeggiata lungo il corridoio". Shakespeare!
Poi un medico o un infermiere mi poneva una serie di domande.
"Come ti chiami?"
"Jonathan Gluck."
"Dove sei?"
"Ospedale del Monte Sinai".
"In quale città?"
"New York."
"Quanti anni hai?"
"Cinquantotto."
"Cos'è quello?" [Indica la televisione.]
"Un televisore."
Ecc.
Infine, mi chiedevano di alzare la mano destra, di toccarmi il naso con un dito, o qualcosa del genere.
Il terzo o quarto giorno, quando una delle infermiere mi ha chiesto di alzare la mano, non l'ho fatto subito.
Fece una pausa.
"Stai bene, Jonathan?" chiese.
"Non hai detto 'Simon dice'", dissi.
Per la cronaca, lei rise.
Un altro problema era la noia.
Per passare il tempo, ho guardato la seconda stagione di The Bear (eccellente). Ho letto due libri scritti da ex colleghi ( Bad Summer People di Emma Rosenblum e The Eden Test di Adam Sternbergh). Ho finito tre raccolte di cruciverba del New York Times (il mio gioco di cruciverba non è mai stato così forte). E ho guardato letteralmente ogni minuto del Tour de France, più di ottanta ore di gare ciclistiche trasmesse in TV. (Guardate su YouTube l'entusiasmante vittoria di Jonas Vingegaard nella cronometro della 16a tappa, in cui infligge un colpo decisivo al rivale di lunga data Tadej Pogačar.) Dato che guardare lo sport in TV è sempre stato per me una specie di Prozac, ho inserito qualche decina di partite di Wimbledon (felice per Carlos Alcaraz, dispiaciuto per Ons Jabeur), il torneo femminile di golf degli US Open (congratulazioni alla vincitrice per la prima volta di un Major Allisen Corpuz) e una dose serale di partite degli Yankees e dei Mets (tutte ugualmente e piacevolmente noiose) per buona misura. Alla domanda se ho guardato un torneo di cornhole su ESPN, mi rivolgo al quinto. (Forza, Jamie Graham!)
Se percepite un tema di evasione, non avete torto. Durante il mio ricovero in ospedale per il trattamento DCEP, avevo letto "Endurance" , il resoconto di Alfred Lansing sulla sfortunata spedizione di Shackleton. Pensavo che l'epica storia di sopravvivenza potesse ispirarmi (almeno non ero bloccato su una lastra di ghiaccio antartica a mangiare grasso di foca per sopravvivere), e in un certo senso lo era. Ma forse era anche un po' troppo intensa. La mia saga, decisi, era già abbastanza straziante.
Vi risparmierò le mie lamentele sul cibo dell'ospedale. In realtà, non lo farò. Ma le limiterò al caffè. Il caffè era orribile. Spaventoso. Probabilmente malvagio. In effetti, esito a dargli dignità chiamandolo caffè. Era Nescafé istantaneo, quello che confezionano in quelle piccole bustine sottili per farle sembrare europee, versato in un bicchiere di polistirolo pieno di acqua tiepida. Avete presente le piccole pozzanghere che si formano sul ciglio della strada dopo un temporale, quelle con le macchie d'olio color arcobaleno in superficie? Il caffè non aveva quel sapore; aveva un sapore peggiore. Vi è mai capitato di dimenticare di cambiare il filtro dell'acqua sotto il lavello della cucina per tre anni, finché non è così saturo di sporco e batteri da poter essere considerato un sito Superfund? Immaginate di strizzare quel filtro e bere il prodotto finale. Poi considerate il fatto che il caffè aveva un sapore dieci volte più cattivo.
Mettiamola così. Il quarto giorno, ho iniziato ad andare di nascosto allo Starbucks nell'atrio dell'ospedale, nonostante il rischio di infezione che comportava, per prendere la mia dose di caffeina. In altre parole, il caffè dell'ospedale era così cattivo che ho rischiato la vita per non berlo.
Il lato positivo è che, dato che ero ormai gravemente immunodepressa, mi è stata assegnata una stanza singola. Questo significava che avevo molte ore libere. Didi mi ha confidato che a volte le piace andare in viaggio d'affari perché stare da sola in una stanza d'albergo le offre una rara via di fuga dalle mie esigenze, dai bambini, dai gatti e da tutto il resto. È un tempo prezioso per stare da sola. Questo pensiero potrebbe anche non avermi sfiorato la mente.
Una mattina, mentre tornavo in camera dopo aver preso un caffè nella hall, mi sono imbattuto in un post-it giallo accanto ai pulsanti Su e Giù dell'ascensore.
C'era scritto: "Ogni giorno sulla Terra è un buon giorno! Baci e abbracci."
Alla persona che ha scritto quel biglietto dico: "Amen".
Il giorno delle dimissioni è stato martedì 11 luglio. Ho fatto un ultimo controllo ("Hai dolore?"), mi hanno rimosso il catetere e sono stata libera di andare.
Didi aveva portato una borsa piena di trucco, smalto e creme per il viso come regalo di ringraziamento per il personale infermieristico. L'abbiamo lasciata all'infermiera capo e ci siamo diretti subito verso le uscite, come dicono nei programmi televisivi dell'ospedale.
Mentre ci dirigevamo verso gli ascensori, ho incontrato una donna che chiamerò Barbara. Barbara era un'altra paziente del CAR-T e una delle accompagnatrici del corridoio. Anzi, no. Era proprio lei ad accompagnarci nel corridoio. Era lì fuori ogni giorno, marciando avanti e indietro, per un'ora o più, a un ritmo almeno il triplo di quello di tutti noi. Aveva forse sessantacinque anni e un'aria forte e calma. Sembrava dire: "Sono consapevole del tuo potere, cancro. Ma mi dispiace, non mi sconfiggerai".
Era ovvio che me ne sarei andato: avevo con me la valigia.
In precedenza, io e Barbara avevamo chiacchierato un paio di volte e scambiato due chiacchiere. Ma in quel momento non avevamo bisogno di parlare. Ci capivamo perfettamente, quasi telepaticamente. Quello che ci stavamo dicendo era: "Mi dispiace. Capisco. Buona fortuna".
Adattato da Un esercizio di incertezza , Harmony Books 2025
esquire





