Due note sulle riparazioni.
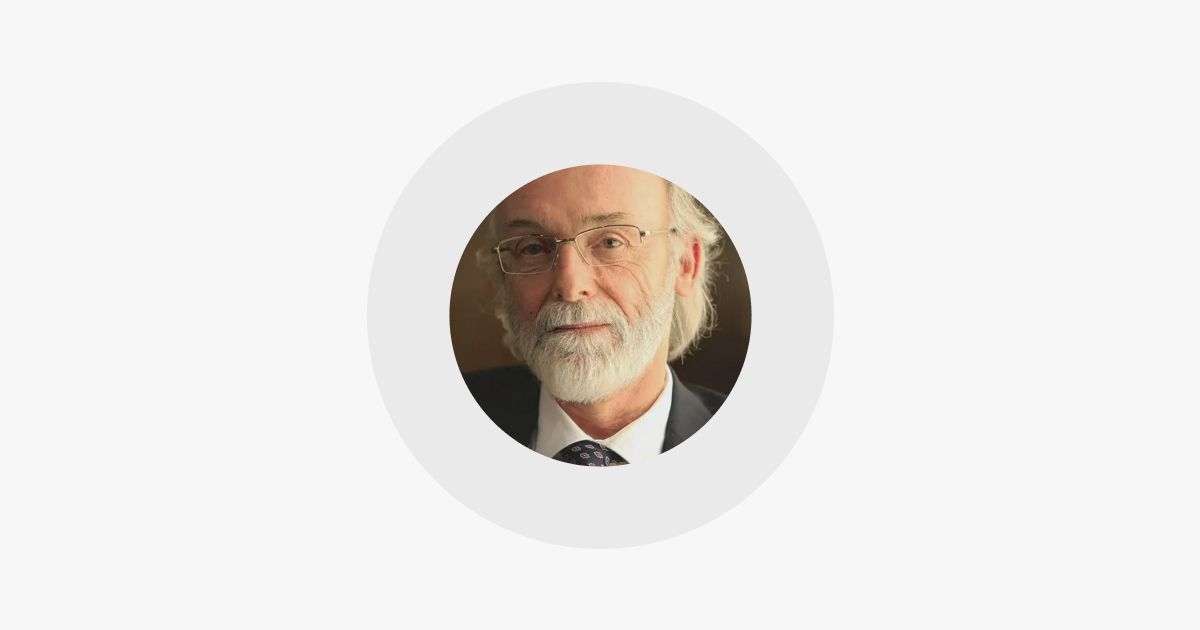
Il mese scorso è uscita la quarta raccolta di cronache su temi di storia coloniale che pubblico dal 2017. Come le precedenti, è stata pubblicata da Guerra e Paz e si intitola "Reparations and Other Historical Penitences" . La copertina mostra Seh-Dong-Hong-Beh, una comandante delle Amazzoni, o donne guerriere del Dahomey, che tiene in mano la testa decapitata di un uomo di colore, in un disegno di Frederick E. Forbes (vedi immagine).

Forbes, ufficiale della Royal Navy, visitò il Regno del Dahomey a metà del XIX secolo, vi soggiornò per molti mesi e ci lasciò, in un libro di memorie pubblicato nel 1851 , un resoconto del suo soggiorno e diverse illustrazioni degli abitanti del regno africano. La rivista Expresso ha gentilmente menzionato la mia collezione nella sua sezione libri, cosa di cui sono grato, ma sorprendentemente, invece di riprodurre l'immagine di copertina, come di consueto, l'ha sostituita con una fotografia di ferri e altri strumenti presumibilmente usati dagli europei per immobilizzare gli schiavi. In altre parole, ha sostituito l'immagine della brutalità africana con un'allusione alla brutalità europea. Si è trattato di una semplice scelta di impaginazione o di una riluttanza politicamente corretta a denunciare la violenza che gli africani si infliggevano a vicenda? Non posso dirlo, e non voglio speculare sulle intenzioni, ma è certamente insolito...
Immagini a parte, Expresso afferma che le riparazioni sono "uno dei principali argomenti di discussione odierni" e afferma giustamente che sono contrario. E perché sono contrario alle riparazioni per le persone che affermano di essere discendenti di schiavi? Per una serie di ragioni che ho spiegato nel tempo, alcune delle quali si trovano in questa raccolta, e soprattutto perché credo che le riparazioni necessarie fossero già state fatte nel XIX secolo, quando i popoli occidentali, in particolare gli inglesi, proibirono e soppressero la tratta transatlantica degli schiavi e posero fine alla schiavitù. Ho difeso questa posizione per iscritto e in diretta, in un dibattito nel programma "É ou Não É?" su RTP, che ha molto infastidito il pubblico woke . Alcune di queste persone hanno reagito immediatamente. Con una chiara propensione a dilungarsi su ciò che non sa, la editorialista di Público Luísa Semedo ha persino fatto un curioso parallelo. Ha scritto quanto segue: "E come si aspetta (João Pedro Marques) che lo prendiamo sul serio quando oggi, in un dibattito televisivo, è capace di usare con assoluta convinzione argomenti così stravaganti come 'abbiamo già riparato il crimine della schiavitù perché lo abbiamo fermato e perché ci è costato tanto fermarlo', che possiamo riassumere così" - e il paragone è di Luísa Semedo - "se un uomo smette di picchiare una donna, questo è già riparazione per il crimine, e la donna non può che esserne grata, soprattutto perché all'uomo è costato tanto smettere di picchiare. Quando si dice che non si può guardare il passato con gli occhi del presente... Allora che occhi ha JPM?"
Bene, Luisa Semedo, questi sono gli occhi di qualcuno che non ha paraocchi ideologici che gli impediscono di guardare sia a destra che a sinistra, qualcuno che per fortuna non soffre di diplopia, che gli fa vedere immagini che duplicano e complicano i problemi abolizionisti con questioni di genere – no, non condivido l'agenda dell'intersezionalità – e soprattutto, gli occhi di qualcuno che sa qualcosa di storia. Ed è principalmente per quest'ultima ragione che ti dico che l'analogia con un uomo che picchia una donna può venire solo da qualcuno che non ha la minima idea di cosa sta parlando. È un'analogia inutile perché non è andata così. Gli occidentali non hanno semplicemente smesso di praticare un'attività condannabile e condannata, cioè non hanno semplicemente "smesso di picchiare" – per usare l'infelice paragone di Luisa Semedo – hanno anche cercato di impedire ad altri, in particolare a molti capi e re africani, di continuare a farlo. Sì, ci sono stati paesi – la Danimarca, i Paesi Bassi – che hanno semplicemente interrotto la tratta degli schiavi. Ma il Regno Unito, la Francia, il Portogallo e altri paesi occidentali non si limitarono ad abolire questa pratica; cercarono anche di sopprimerla. Proibire e reprimere non sono sinonimi, non sono la stessa cosa, Luisa Semedo. Per sopprimere la tratta transatlantica degli schiavi, e anche il commercio nell'Oceano Indiano, fu necessario pagare indennizzi, effettuare interventi militari a terra e schierare navi da guerra per pattugliare quegli oceani.
Fu uno sforzo sostenuto per decenni, il cui costo fu estremamente elevato. Il Regno Unito, ad esempio, spese circa 12 milioni di sterline. Il Portogallo, le cui navi da crociera iniziarono a operare più tardi degli inglesi, aveva speso, fino al 1860, cioè nei primi vent'anni della sua azione repressiva, circa 4 milioni di contos, una spesa enorme date le sue risorse finanziarie dell'epoca. A ciò si deve aggiungere il costo in vite umane. Le coste africane erano altamente mortali a causa di febbri tropicali (malaria, febbre gialla) e altre malattie. Fu così mortale che la Sierra Leone e, per analogia, altre parti della costa, divennero note come "la tomba dell'europeo" – o " la tomba dell'uomo bianco ", in inglese – un'espressione coniata nel 1819 dal portoghese César de Figanière y Morão. Permettetemi di fare tre o quattro esempi: nel 1841, 25 dei 140 uomini dell'equipaggio del Wolverine morirono sulle coste del Biafra; 46 marinai su 50 che entrarono nel fiume Pongos morirono in sei giorni; secondo le statistiche britanniche, la mortalità per malattie sulle navi in servizio in Africa era cinque volte superiore a quella sulle navi che solcavano i mari d'Europa; e chiunque legga il romanzo Eugénio , scritto a metà del XIX secolo dall'ufficiale della Marina Francisco Maria Bordalo, capirà immediatamente il sacrificio e l'altissimo rischio per la vita che comportava il servizio presso la stazione navale di Luanda.
Qual è stato il risultato pratico di questo sforzo e di questo rischio? Gli inglesi sequestrarono 1.575 navi negriere; i francesi 214; i portoghesi 168; gli americani 68; ecc. La politica di repressione richiese l'impiego di numerose risorse militari e finanziarie e costò vite umane, non solo per malattie ma anche per i combattimenti con i mercanti di schiavi. Il Portogallo partecipò a questa repressione. Ho affrontato questo aspetto della storia portoghese in Africa nel 1999, in un'opera ora fuori catalogo , ma fortunatamente esiste, per chi è interessato all'argomento, un buon libro più recente che narra in modo molto dettagliato l'intervento della Marina portoghese nella lotta contro la tratta degli schiavi.
In breve, ciò che è più importante sottolineare, nel contesto di questa nota, è che, per quanto riguarda la tratta degli schiavi africani, i paesi occidentali – incluso il Portogallo – non hanno avuto un atteggiamento meramente passivo di "fermare le percosse", come immaginano l'editorialista Luísa Semedo e altre voci woke. E per quanto riguarda la fine della schiavitù, basta considerare cosa sia stata la Guerra Civile Americana, che ha causato la morte di oltre 600.000 persone, per capire che anche in quel caso non ci fu passività, non si trattò semplicemente di "fermare le percosse". Pertanto, non ci sono ulteriori riparazioni da effettuare. La fine della tratta degli schiavi e della schiavitù costituisce una riparazione sufficiente, e tale riparazione è stata effettuata nel XIX secolo, circa 200 anni fa.
observador





