Ovidio e le metamorfosi del rifiuto
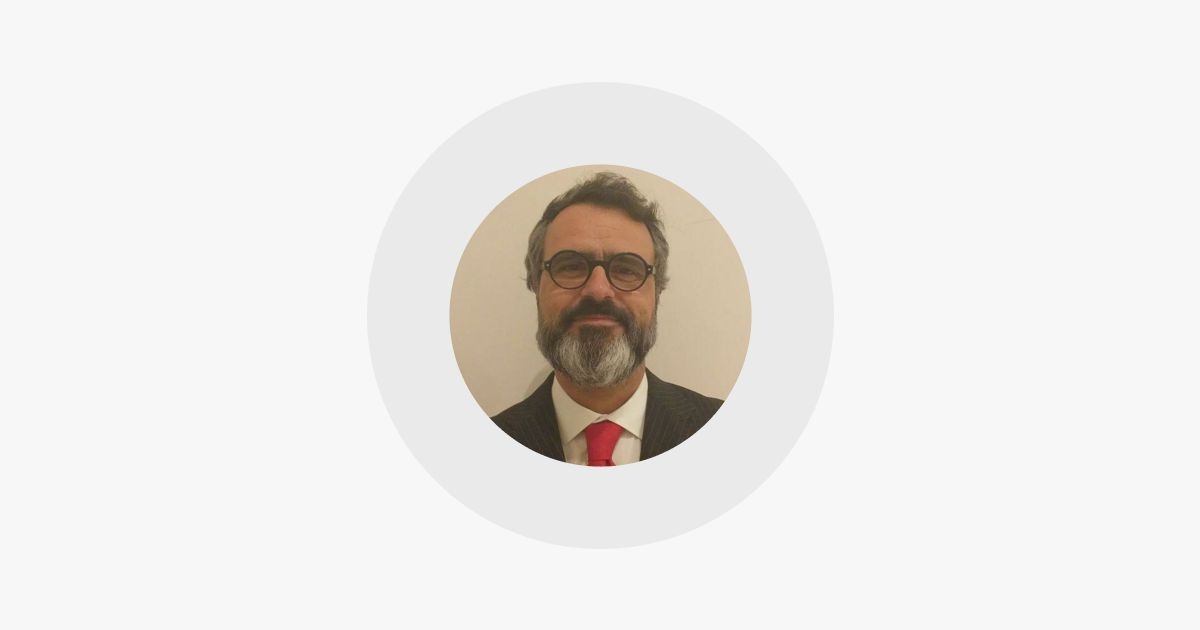
La coscienza inizia dove finisce il gesto, in quel luogo preciso in cui il corpo, aspettandosi di trovare un altro, trova solo aria: lo spazio che allora si apre – quel vuoto – è il pensiero. Il rifiuto dell’altro non è solo una ferita d’amore: è l’origine dell’interiorità. Ciò che non ci tocca diventa ciò che dobbiamo immaginare.
Lucrezio affermava che il mondo è un insieme di atomi in caduta: convergono, divergono, agonizzano e, in questa caduta infinita, una piccola deviazione – clinamen , come lo chiamava – dà origine a tutte le cose. Il rifiuto, nel cuore umano, agisce come una deviazione simile: uno spostamento nella collisione accesa dei corpi. Da esso nascono l'autocoscienza, la solitudine, il linguaggio, perché chi è rifiutato scopre che il mondo ha un esterno. Prima viveva nella continuità tra carne e respiro; ora guarda il suo corpo come qualcosa di abbandonato, arrossisce, si nomina. In principio c'era la pelle; poi venne il rossore.
"Et erubescebam me ipsum " – scrisse Agostino la notte del suo desiderio, e non ci vuole un dottorato in Lettere Classiche per capire che non si tratta di pudore, ma di metafisica: la vergogna è la rottura improvvisa tra ciò che si sente e ciò che si vede. La coscienza è quella fessura: la ferita invisibile della visibilità. Arrossire non è confessione, ma divisione: il sangue affluisce al viso a mostrare il ritiro dell'anima. Il rifiuto dell'altro diventa il rifiuto di sé. L'io nasce dalla vergogna, non dalla conoscenza: molto prima di dire "Penso", avevamo già detto silenziosamente "Non posso essere questa carne".
Gli antichi la chiamavano modestia , una parola curiosa che in ultima analisi significava modestia , terrore, riverenza, riverbero . Non una virtù, ma una vertigine, un movimento di ritirata di fronte a ciò che, mutevole e cangiante, supera la nostra comprensione.
Quanto abbiamo bisogno, come Ovidio, non di descrivere la metamorfosi, ma di abitarla: per lui, il cambiamento non era un evento, ma la grammatica stessa dell'esistenza. Ogni creatura, ogni desiderio, ogni ferita cerca un'altra pelle; gli dei sono solo maschere indossate da questa sete insaziabile di sfuggire alla forma. Sapeva bene che l'identità è solo una pausa nella grande deriva dell'essere, che vivere è già diventare nebuloso. Nei suoi versi, la metamorfosi si rivela come la legge segreta del mondo: nulla rimane ciò che afferma di essere; tutto scorre verso la somiglianza successiva.
La poesia di Ovidio non consola – ci ricorda che i nostri corpi sono già mito, che i nostri nomi sono solo rifugi temporanei nell'incessante migrazione delle forme: Dafne, in fuga dalle braccia che la bramavano, si trovò trasformata in albero, e la metamorfosi non fu punizione, ma salvezza: divenne corteccia per sfuggire alla pelle, per vivere nel rifiuto di essere toccata. La coscienza è quella corteccia che si indurisce sulla ferita del sentirsi esposti; Atteone vide troppo: sorprese Artemide al bagno e, trasformato in cervo, fu divorato dai suoi stessi cani; Mirra ama ciò che non poteva toccare, il suo desiderio la trasforma anch'essa in albero; la linfa che sgorga dalla sua corteccia – e che i Magi offrirono al Bambino – è il suo dolore silenzioso, la resina indurita di passioni mai vissute.
Platone considerava l'anima prigioniera del corpo, ma forse è proprio il corpo il vero prigioniero del rifiuto dell'anima, quella cellula costruita dal suo stesso tremore. Rifiutare il proprio corpo significa inventare l'invisibile. È qui che inizia ogni metafisica: l'idea, la legge, il dio – ognuno a suo modo un surrogato dell'insopportabile vicinanza della pelle.
I primi templi non furono costruiti per celebrare la vita, ma per sfuggirle: colonne si ergono dove i corpi non possono inginocchiarsi senza tremare. L'architettura è una fuga pietrificata, incontaminata dal tatto. Gli dei si travestono sempre per avvicinarsi ai mortali. Assunsero forme diverse – toro, cigno, fiamma – perché non osavano essere presenti nella loro forma: persino il divino teme la violenza dell'incarnazione. Diventare consapevoli significa imitare gli dei – nascondersi in forme, nomi, atteggiamenti, concetti; proteggersi, in breve, dall'intimità primordiale.
Ancora Agostino: Factus sum mihi magna quaestio (Sono diventato per me una grande domanda) e lo scrive non in pace, ma nello sfinimento, perché la domanda è il residuo del rifiuto, l'ombra di un abbraccio perduto. La paura non è l'opposto del desiderio, ma la sua eco. Il desiderio richiama un contatto che non può sopportare, e la paura è l'intelligenza di quella memoria: essere rifiutati è diventare spettatori del proprio corpo. Le membra che un tempo si estendevano all'esterno sembrano ora appartenere a un'altra persona. Il sé inizia come un'autopsia: ci sezioniamo per capire perché non siamo stati scelti: ogni "io" nasce insieme a un "perché".
I primi filosofi dell'anima furono uomini che non trovavano pace nell'amore e cercavano l'astrazione perché il corpo aveva negato loro la grazia. Le idee nascono dalla freddezza del rifiuto: astinenza, solitudine e intelletto non sono virtù, ma metamorfosi del dolore. Chi è stato rifiutato impara la distanza, perché sa che la prossimità non è mai garantita, che la presenza può scomparire. Ed è da questa saggezza che nasce l'arte: pittura, musica, poesia – ognuna un tentativo di dare forma all'assenza. La bellezza è la distanza resa visibile.
Nell'Eneide , Didone ama e viene abbandonata. Maledice il mare che la separa dalla nave in partenza. Il mare è la coscienza stessa: in movimento, senza profondità, irraggiungibile, uno specchio che non può essere contenuto. I rifiutati diventano marinai di questo mare. La paura li accompagna: la paura di tornare al corpo, la paura che l'accettazione dissolva il fragile sé costruito dalla perdita. Si impara ad abitare il rifiuto come un rifugio. Diventa l'architettura della solitudine. Segue la vergogna. Non è umiliazione, ma il riconoscimento che esistiamo sotto lo sguardo di un altro che non ci ha scelti. Lo sguardo rifiutante continua a bruciare dentro. Lo ripetiamo incessantemente, interiormente, finché non diventa la luce dell'introspezione e la coscienza è l'immagine residua di quello sguardo.
C'è una sorta di saggezza in questa sconfitta: essere rifiutati significa percepire il limite del desiderio. A questo limite, la chiarezza fiorisce. Scopriamo di essere finiti, che il corpo non può costringere all'amore, che nessun gesto garantisce la reciprocità. Il rifiuto dell'altro è una lezione, in miniatura, di mortalità.
Eppure, in ogni rifiuto, qualcosa resta inestinguibile: il desiderio non muore; si volge verso l'interno, si trasforma in luminosità, vigilanza, attenzione. Chi viene rifiutato ascolta, ed è dall'ascolto che nasce il linguaggio. Ogni frase è una risposta al silenzio dell'altro, e in questa risposta costruiamo un mondo.
Essere respinti, arrossire, temere: questi non sono incidenti della vita, ma il suo inizio. Da essi si dispiega l'io interiore. L'io è il residuo di un gesto interrotto; è la voce che rimane quando l'abbraccio svanisce. Chi è stato respinto porta con sé il ricordo della vicinanza, lo trasforma in distanza e la distanza in significato.
Nel Fedro , Platone scrisse che l'anima acquista ali quando vede la bellezza – ali che simboleggiano il volo, ma anche la fuga. La bellezza ferisce; le ali spuntano per sfuggire al tocco della vista. Eros concede la conoscenza solo a coloro che possono sopportare la sua bruciante assenza. La vergogna custodisce questa soglia. Non è l'opposto della libertà; ne è la condizione. Senza vergogna non c'è distanza, e senza distanza non c'è sé.
La distanza estetica è l'eco del primo ritiro della carne. Leggiamo gli antichi perché tremarono per primi: Seneca avvolge il terrore nella serenità; Ovidio nasconde il desiderio nelle metamorfosi; Agostino nasconde il desiderio nella preghiera; Pascal nasconde la vergogna nella matematica. Tutti corpi che fuggono nelle parole.
Il rifiuto del corpo è la nascita dell'interiorità: ciò che è stato rifiutato all'esterno è nascosto dentro; l'anima è l'eco del silenzio del corpo. Forse un giorno il rifiuto finirà: allora il pensiero cesserà, il linguaggio si libererà, la pelle respirerà di nuovo. E quella sarà la morte. O l'innocenza. O il silenzio.
Fino ad allora, il sé rimane nello spazio tra il tatto e la fuga, tra il desiderio e la paura. Viviamo in questa esitazione e la chiamiamo coscienza.
observador





