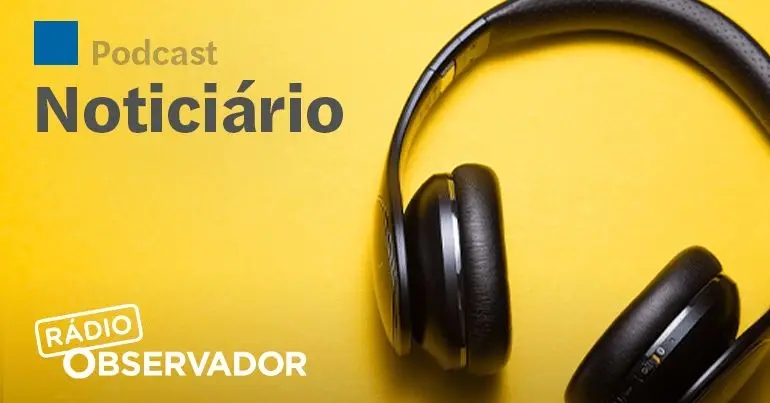Identità di genere, realtà e cosa ci dicono i dati

Il tema dell'identità di genere è diventato centrale nel dibattito pubblico, e giustamente. Ma nel nostro entusiasmo per l'inclusione e la protezione delle minoranze, non stiamo forse perdendo di vista alcune evidenze fondamentali sulla realtà umana?
In questo testo condivido una breve riflessione su questo difficile equilibrio tra empatia e dati, tra eccezione e regola.
È noto che viviamo in un'epoca in cui l'identità di genere è diventata uno degli argomenti più dibattuti, e anche più delicati, nella sfera pubblica.
Soprattutto in Occidente, la visibilità delle persone transgender è aumentata considerevolmente. Ciò ha portato con sé importanti risultati in termini di riconoscimento e tutela dei diritti. Ma ha anche portato con sé un altro fenomeno: confusione concettuale, posizioni estreme e, a volte, una tendenza a ignorare o relativizzare dati oggettivi sulla realtà umana.
E che realtà è questa?
Gli studi disponibili suggeriscono che solo tra lo 0,5% e l'1% della popolazione si identifica come transgender, a seconda del contesto e della metodologia utilizzata. I casi clinici di disforia di genere – ovvero situazioni in cui vi è disagio psicologico associato a questa incongruenza e necessità di intervento medico – sono ancora più rari: variano dallo 0,005% allo 0,014% della popolazione, secondo dati internazionali.
Ciò significa che tra il 99,5% e il 99,9% delle persone si identifica con il sesso biologico con cui è nato.
Questa è una semplice realtà statistica, ma a volte è "scomodo" riconoscerla. Perché?
Forse perché viviamo in un'epoca in cui qualsiasi riferimento a "norme" o "maggioranze" può essere interpretato come esclusione. Ma è davvero così? Non stiamo forse confondendo il riconoscimento della realtà con la discriminazione?
Riconoscere la regola non significa rifiutare l'eccezione. Tutt'altro. Possiamo comprendere e proteggere veramente le minoranze solo se sappiamo come inserirle nel tutto. Altrimenti, rischiamo di cadere in un nuovo tipo di distorsione: voler riformulare tutto il linguaggio, la biologia e persino l'organizzazione sociale sulla base di un numero statisticamente marginale.
È possibile, e auspicabile, direi, fare qualcos'altro, ovvero mantenere un lucido equilibrio tra il rispetto per l'esperienza di ogni individuo e la salvaguardia della chiarezza sulla natura umana.
La biologia è importante. E la scienza continua ad affermare che la specie umana è sessualmente dimorfica, ovvero strutturata in due sessi biologici distinti, seppur con variazioni ed eccezioni. Questo non impedisce a qualcuno di vivere la propria identità di genere in modo diverso e quindi di meritare dignità, rispetto e protezione. Ma questo rispetto non deve necessariamente implicare la negazione di ciò che è osservabile, misurabile e comune alla stragrande maggioranza della popolazione.
C'è spazio, e bisogno, dico, per tutto. Sia per l'empatia che per il rigore, per l'inclusione che per la verità, per i diritti che per i dati.
La sfida, quindi, sta nel trovare un equilibrio difficile ma essenziale: proteggere le minoranze senza tentare di riscrivere la natura umana, né cadere nella tentazione di trasformare l'eccezione in regola o di imporre una nuova ortodossia ideologica che sostituisca i fatti con le percezioni.
E questo richiede coraggio, intelligenza e, soprattutto, l'impegno verso qualcosa che tanto ci manca nel dibattito pubblico: il semplice buon senso.
observador